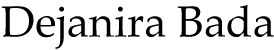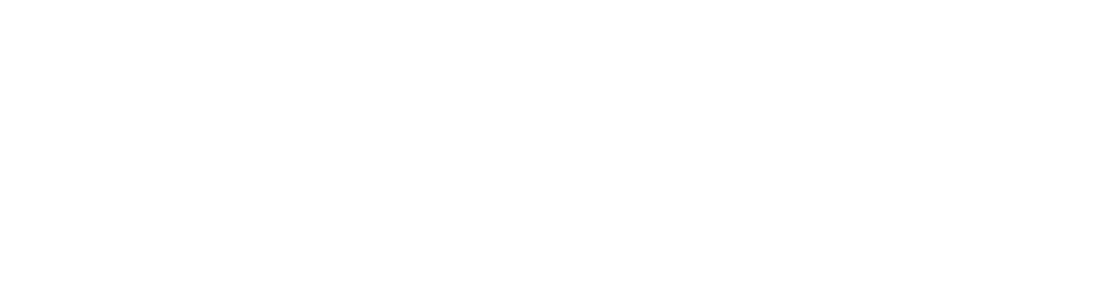“Ho paura dell’infinito: l’arte è andare alla ricerca dei Jumblies”. Dejanira Bada intervista Pietro Geranzani. Dialogo tra moglie & marito
P.G. Non deve essere una roba da ridere.
D.B. Non rideremo non ti preoccupare! Non è da te.
P.G. Riderò, invece, perché la condizione mi fa ridere.
D.B. Allora, Signor Geranzani, vuole che le legga l’introduzione?
P.G. Fai tutto quello che devi.
Ho conosciuto mio marito grazie a un’intervista.
Lavoravo per un sito come critica musicale e d’arte. Una sera, a una festa a casa di un amico a Milano, c’era quest’uomo, in piedi, poggiato al bancone della cucina. A un certo punto il padrone di casa ha detto che bisognava festeggiare, perché l’uomo in questione avrebbe partecipato all’Arsenale alla Biennale di Venezia quell’anno. Era il 2011. Ero lì con una mia amica che mi disse: “Intervistalo!”. Allora sono andata a chiedergli chi fosse, cosa dipingesse.
Nel giro di qualche settimana facemmo l’intervista via mail. Avrei dovuto incontrarlo ma non me la sentii. Eravamo entrambi fidanzati, e c’era qualcosa in quell’uomo… Un anno dopo lo incontrai a un’inaugurazione, per caso. E non ci siamo più lasciati. Oggi, finalmente, posso fargli quella famosa intervista di persona, e in occasione di una mostra speciale, “Le loro teste sono verdi e le loro mani sono blu”, che si terrà in un luogo suggestivo, la Fondazione Sangregorio Giancarlo a Sesto Calende (VA).
Stiamo parlando di Pietro Geranzani.

D.B. Che cosa significa per te questa mostra. So (sai com’è) che durante la pandemia sei stato fermo per un po’, come molti, come tutti.
P.G. Ride. Significa ritorno, confronto. Ho lavorato per tutto questo tempo, anche se non ho esposto nulla. Ho passato gli anni della pandemia ad accumulare quadri e questi quadri erano in qualche modo legati al viaggio. Noi viaggiamo molto, dall’Africa al Medio Oriente, dagli Stati Uniti, all’India, Tibet, Nepal… non serve che te li elenchi. Stare fermi, chiusi, comporta una specie d’imprigionamento, una cattività che credo abbiano sentito tutti. Oggi, riguardando i miei quadri, credo di aver capito che fossero un po’ il mio modo di tornare in quei luoghi. Quando viaggiamo sai che faccio dei film, che sono con l’occhio meccanico attaccato alla testa. Filmo le persone, è un modo per tentare un’interazione; e poi i luoghi, ho bisogno di fissare da qualche parte le immagini dei luoghi. E da alcuni di questi film ho tratto dei fotogrammi che poi ho tradotto in pittura. Per me, in quei giorni di pandemia, era importante non solo recuperare l’immagine di quei posti ma riviverli, risentirne gli odori, rivederne i colori, e dipingerli è stato un po’ come ricostruire pazientemente le mie sensazioni. Nel testo del catalogo della mostra, scritto da Angelo Crespi, c’è un punto in cui cita Paul Bowles e il suo Il tè nel deserto. Uno dei protagonisti traccia una fondamentale distinzione fra i turisti e i viaggiatori, e così faccio anche io:
“mentre per i primi esiste sempre un luogo originario cui far ritorno, i secondi fanno del viaggio una condizione esistenziale permanente”.
“Viaggiare”, scrive ancora Crespi, “significa mettere alla prova i propri schemi mentali, mettere alla prova i propri sentimenti, mettere alla prova i propri occhi”.
Quando eravamo al Manikarnika Ghat a Varanasi – il posto più sacro per gli induisti, perché credono che essere cremati lì e far gettare le proprie ceneri nel Gange interrompa il ciclo delle reincarnazioni – ci siamo particolarmente emozionati. Ho avuto il permesso di fare delle riprese, ho vissuto quell’esperienza incredibile avvicinandomi da privilegiato fino al limite delle fiamme, fino a vedere i corpi neri e deformati dal fuoco spezzarsi e cedere a un passo da me, con il naso tappato dalla cenere densa e bruciante, con gli occhi lacrimosi. Non avevo mai vissuto niente di simile. E durante i due anni di pandemia ho dipinto proprio due quadri tratti dai fotogrammi del film girato a Varanasi. Non si tratta di illustrazione. Ho scelto di dipingere un momento dove non si vedono né fiamme né corpi in combustione, o il funerale. Si vede il passaggio di alcuni individui che fanno delle cose che non si capiscono tanto bene. È un momento intermedio. Non è l’apice dell’azione, sta per succedere ma potrebbe andare in qualunque direzione, o forse è già tutto finito, e questo modo di raccontare, sbagliando i tempi, gli ingressi, mi piace, perché sviluppa un aspetto cui tengo molto nell’arte: quello evocativo, che permette a chi guarda di aggiungere gli elementi assenti dal quadro con la propria fantasia ed esperienza. È così che si instaura un dialogo. E il dialogo è il motore di questa mostra, in questo caso tra me e Sangregorio, lo scultore, poeta, viaggiatore. Lui è stato un grande viaggiatore negli anni ’40-’50, fino agli anni tardi della sua vita, e ha avuto l’opportunità di vedere il mondo in un altro modo. Sempre Crespi, nel testo del catalogo, scrive: “La questione dell’esplorazione lega Geranzani a Sangregorio, solo che il secondo per anagrafe ha potuto residualmente essere protagonista dell’atto di esplorare, certo in una chiave da antropologo e non più da vero esploratore ottocentesco, mentre a Geranzani è stata negata anche questa possibilità poiché siamo nel mondo e nel tempo del non-plus-ultra, non esistono più spazi da perlustrare e scoprire. Così lo sguardo di Geranzani si volge altrove, verso l’alto oppure verso il basso, verso il cosmo o nell’imo della terra”.
L’incanto dell’esploratore ottocentesco si è rotto. Il buon selvaggio non esiste, io non l’ho mai incontrato e credo nemmeno Sangregorio che “fotografa a distanza, senza patina o patema d’artista, senza fingere di capire” (Migrazione nello sconosciuto. Scritti di Giancarlo Sangregorio, Skira, 2021). Noi non capiamo. Partecipiamo a nostro modo. Ora, parlando, mi viene in mente che un altro motivo per il quale dipingo quegli istanti che chiamo intermedi, quelli cioè dove l’accadimento non è chiaro, è perché non capisco pienamente quello che sta succedendo, e anch’io mi tengo distante.
Mi è cara, anche se un po’ la detesto, una certa frase di Mark Twain che si trova in The Innocents Abroad (che si chiama anche, guarda un po’, I nuovi pellegrini):
“Che cosa posso vedere a Roma che non sia già stato visto da altri? Che cosa posso toccare che altri non abbiano già toccato? […] Che cosa posso scoprire? Nulla. Assolutamente nulla. Qui muore uno degli incanti del viaggio”.
Già allora c’era la sensazione che il mondo fosse stato scoperto e mappato tutto. Questo stringe i confini, nega al viaggiatore contemporaneo una visione del mondo ancora incantata. Del viaggio resta l’illusione, e sull’illusione ho condotto questo mio lavoro. Ci troviamo così, dopo un viaggio di poche ore, al cospetto di persone così tanto diverse da noi e ci illudiamo che incontrandole per pochi istanti queste ci diventino intime e non una sterile raccolta di feticci, souvenir come trofeo. È un’illusione, lo so, come posso pretendere d’aver conosciuto davvero qualcuno con cui non riesco quasi a dialogare? Da quando noi viaggiamo insieme, diversamente da come facevo prima, è diventato molto importante l’aspetto naturale del mondo. Noi andiamo spesso a vedere luoghi che sono a te, in particolar modo, molto cari, come i deserti, i grandi spazi sconfinati. Tu sei una collezionista di canyon.

D.B. E di deserti.
P.G. Hai visto i grandi canyon del mondo e ogni volta ho visto la meraviglia nei tuoi occhi, e questa meraviglia me l’hai trasmessa. Sono entrato in quella dimensione incantata anche grazie a quel modo che tu mi hai insegnato. Ti fermi e mediti, magari sul crinale di una duna, o sullo strapiombo di una scogliera, e ti osservo, e mi piace guardarti. Prima andavo in giro a cercare le tracce dell’uomo, le sue testimonianze, che ne fanno la storia e la tradizione. Cercavo gli uomini attraverso quello che avevano costruito.
D.B. Io cerco il Nulla.
P.G. Lo so.
D.B. Viaggiare ci è mancato come l’aria. E, sì, non credo che sia un caso che questa mostra parli di viaggio, nel mondo e dentro se stessi. Cos’è per te il viaggio, quindi, e perché hai scelto proprio questo tema?
P.G. Quello che rappresenta per me il viaggio e questa mostra, l’ho trovato nella poesia The Jumblies di Edward Lear, poeta dell’Ottocento inglese, quasi una filastrocca, bella per i grandi e i piccini.
Sono andati per mare in un Setaccio, l’han fatto
In un setaccio sono andati per mare:
A dispetto di quel che i loro amici potessero dire,
In una mattina d’inverno, in un giorno di tempesta,
In un Setaccio sono andati per mare!
E quando il Setaccio girava e rigirava,
E tutti strepitavano: “Affogherete!“
Han gridato a gran voce, “Il nostro Setaccio non è grande,
Ma non ci interessa un accidente! non c’importa un fico!
In un Setaccio andremo per mare!”
Lontane e poche, lontane e poche,
Sono le terre dove vivono i Jumblies;
Le loro teste sono verdi e le loro mani sono blu,
E sono andati per mare in un Setaccio.
Questa mostra è mia, ma è anche di Sangregorio, è la nostra mostra. È un dialogo tra me e uno scultore, un poeta, un viaggiatore ma anche un collezionista di arte etnica, o primitiva che dir si voglia. Lui ha una gran bella collezione e quando l’ho vista per la prima volta nella sua casa, appassionato come sono anch’io dell’arte Oceanica e Africana, ho capito che quello era il punto da cui partire per questa mostra.
Si tratta della visione di un viaggio impossibile. Il setaccio per sua natura non galleggia. Queste persone che sono andate a cercare i Jumblies, sono partite comunque, sono andate oltre quello che sapevano già, dovevano farlo, a costo della vita. Che cosa si cerca quando si viaggia? Qualcosa che magari non esiste nemmeno, come i Jumblies, creature dalle teste verdi e le mani blu. Per me viaggiare è mettersi alla ricerca di qualcosa che non conosco ancora, andare alla ricerca dei Jumblies, appunto. Qualcosa che anche nelle mie letture, anche quando ero ragazzo, nelle mie speranze, cercavo; qualcosa che non conoscevo, che ho mitizzato. Nel corso della storia si è cercato l’El Dorado, Atlantide, il regno di Saguenay o Mu, luoghi leggendari, ma i viaggiatori li cercavano lo stesso. Colombo ha fatto il giro del mondo alla rovescia per andare a cercare un posto che si poteva benissimo raggiungere in modi già conosciuti, ma doveva capire. Poi è arrivato dove è arrivato e ha scoperto i suoi Jumblies. Io viaggio per amor del viaggio, della scoperta, per raggiungere quella condizione che sia io che te vogliamo vivere e arrivare là dove non eravamo mai arrivati prima, anche se magari vedremo cose che molti hanno già visto, perché non è che facciamo strani viaggi difficilissimi, ma il punto è, lo ridico, come si guardano le cose, un’ombra, un profumo, un rumore, un taglio di luce, uno schiamazzo, l’assetto di una strada, il traffico, gli animali, la vegetazione che qua non c’è; vedere una Kentia di cinque metri in natura o un tappeto d’Aglaoneme che colorano un sottobosco tropicale, e dirci con stupore bambinesco “guarda, questa da noi è una pianta d’appartamento”. Oppure vedere l’Hevea brasiliensis con i solchi per raccoglierne il lattice. È la verità delle cose. È il sapore di una banana comprata sui bordi della strada in Africa rispetto a quella che compriamo al supermercato. E non si tratta di gusto per l’esotico o per il folklore della banana africana, si tratta di fermarsi e di cercare di sentire. Per me tutto questo è importante come persona, come uomo, non solo come pittore.

D.B. Durante la pandemia mi dicevi una cosa: si parlava di musicisti, di concerti, di musei, ma mai, mai una volta sono stati nominati i pittori, i galleristi. Eravate come dei fantasmi. Qual è lo stato dell’arte in questo Paese?
P.G. Politica. Cosa vuoi che ti dica. La mia categoria viene vista come non prioritaria.
Vale per tutte le arti, dalla musica al teatro, al cinema. In fondo è sempre stato così, nei periodi di pandemia, la peste in Europa che andava e veniva. Nella storia, le chiusure, i lockdown, erano comuni. Shakespeare, per esempio, durante la peste nel Seicento, vedeva il suo teatro aprirsi e chiudersi frequentemente. Oggi come allora, con una regolamentazione sui generis rispetto ad altre categorie professionali che godono di tutele più chiare, gli artisti sono lasciati indietro. Durante il lockdown è emerso chiaramente quanto gli artisti siano sotto-tutelati e carenti di un vero statuto. In due parole, se sei un poeta vuol dire che te lo puoi permettere, quindi non rompere le palle e considerati comunque un privilegiato. Non è cambiato molto dopo la pandemia. Le riflessioni sono sempre le stesse. I meccanismi e i desideri solo gli stessi. Lo Stato ha i suoi, il collezionista ne ha certi, e così lo stesso investitore. Il gallerista, che se non è un grande gallerista come lo sono stati Daniel-Henry Kahnweiler o chessò, Ambroise Vollard o Leo Castelli, ha comunque i suoi interessi di bottega. I critici, ognuno ha modo suo, hanno spinte molto illuminanti e momenti in cui si devono adattare alle questioni politiche ed economiche dell’arte. È difficile, non posso rispondere con una sola frase. Da quando esiste il collezionismo privato si è in qualche modo innescata questa spirale. Chi compra un’opera d’arte magari la tiene lì per il piacere estetico o per il benessere spirituale che essa genera, ma può essere anche altro, una forma maniacale di accumulo oppure ostentazione. Bah, non so che dirti.
D.B. In questa mostra indaghi anche il viaggio spaziale, ma quando ci è capitato di parlare di infinito e universo in continua espansione, ti agiti. Cosa ti fa paura del concetto d’infinito?
P.G. In questa mostra parlo di archeologia più che dello spazio. Lo spazio in senso stretto, lo spazio siderale, non è l’argomento primo in questa mostra. Ho cominciato a raccogliere le immagini registrate dai satelliti che hanno esplorato la superficie della Luna, di Marte e dei pianeti che ci sono vicini. Quando si va su internet e si guardano queste immagini, in molti si innesca una strana pareidolia, perché sembrano forme artificiali. Tutti in qualche modo abbiamo bisogno di forme nuove, di sognare, d’immaginare cose che scientificamente sono improbabili, e così delle ombre diventano orme e le rocce diventano teste e via dicendo. Tutto questo rasenta l’ambito delle teorie misteriosofiche, della piramidologia, degli alieni senzienti che hanno creato la nostra civiltà; tutta una serie di debordanti fantasie, divertenti, come nei libri di Peter Kolosimo – che oltretutto sono nella libreria di Giancarlo Sangregorio, perché era un appassionato del mistero, di Ufo.
Queste immagini dal satellite, dicevo, mi hanno suggerito una serie di quadri che ho intitolato Strani oggetti sulla Luna, che nella mostra accosto a quadri che invece ho dipinto guardando veri siti archeologici, come la serie di immagini che ho usato degli scavi della città di Ur in Mesopotamia. Si tratta di pochi mucchi di sassi che hanno subìto, nella ricostruzione e nell’interpretazione, la stessa identica sorte delle foto satellitari. Guarda per esempio il palazzo di Cnosso, è la Disneyland dell’archeologia. Quando siamo stati al museo egizio del Cairo, c’erano brani di pitture murali che sono stati staccati, trasportati e conservati lì, e di alcuni restavano solo dei frammenti, collegati da un disegno, che avrebbe dovuto indicare com’erano fatti. È prassi anche in Italia, ovunque, e la trovo sempre una forma di ricostruzione arbitraria. Viene indicato che in quel frammento mancante magari si trovava una mano, la piega di un abito o altro. Vedi che ci hanno messo volute, uccelli, decorazioni, a continuare qualcosa che magari non era così. Qualche archeologo che dovesse leggere queste mie parole magari ribatterà che tutto questo ha la sua concretezza scientifica, ma io non riesco mai a capacitarmene…
D.B. Sì ma io ti ho chiesto cosa ti fa paura dell’infinito!
P.G. Lo so cosa mi hai chiesto, ora ci arrivo. La questione che m’inquieta riguardo allo spazio – infatti ti chiedo sempre di non parlarmene – è il concetto di incommensurabile. Sono sempre sbigottito, spaventato dall’idea che ci sia qualcosa senza fine quando io sono finito. Va bene, l’universo è in continua espansione, è nato forse da un punto, c’è stata un’esplosione, e poi ha iniziato a diffondersi… verso cosa, in cosa, per quanto tempo, infinito? No, non ci riesco. E prima? O ci si appiglia a varie teorie evoluzionistiche o creazioniste – ed evidentemente molte persone ne hanno bisogno per non impazzire – o si lascia stare, non ci si pensa, si rifugge. Credo che sia come guardare direttamente il Sole. Non lo facciamo, sappiamo che ci renderebbe ciechi, conviviamo con la sua presenza ma non alziamo mai lo sguardo, per istinto. Non sono in grado di sostenere questa faccenda di cosa c’era o ci sarà. È che non lo posso immaginare, perché ogni volta è un po’ più grande, un po’ più lontano…
D.B. Immagina di poter chiedere una cosa a Sangregorio. Cosa gli avresti chiesto?
P.G. Mi porti?
D.B. Dove?
P.G. Dove sta andando.
D.B. Io scrivo e medito. Tu dipingi e… dipingi, che alla fine è una forma di meditazione secondo me, come anche la scrittura…
P.G. Punti di vista. Lo dici tu.
D.B. Non solo secondo me… Tranne in alcuni momenti, in cui non dipingi… e non ho ancora capito se quando non dipingi stai comunque solo pensando a cosa dipingere in futuro.
P.G. No, non penso sempre a cosa devo dipingere. Dipingere dovrebbe essere una pratica costante per essere efficace, come suonare. Un musicista deve suonare sempre, ma io dipingo a blocchi d’intensità diversi. Ci sono periodi lunghi in cui non dipingo niente, e periodi in cui dipingo in maniera intensiva. In quei periodi sono un po’ come Pico De Paperis, il papero scienziato, sempre sbadato e immerso nel suo mondo di pensieri…

D.B. Sì, lo so.
P.G. Non partecipo alla vita mondana, non voglio essere disturbato, non voglio che si guardi quello che sto dipingendo, finché non ho finito. Io stesso mi confronto faticosamente con quello che sto facendo, non sono mai soddisfatto e ho mille idee che ribollono in testa. Idee su cosa dipingere me ne vengono spesso. Anche l’altro giorno a tavola, cos’è che t’ho detto che volevo dipingere?
D.B. Mmm, troppe me ne dici…
P.G. Ma sì, dai, l’ultima… perché non me le segno…
D.B. Le pattumiere…
P.G. Le discariche… no…
D.B. Ah sì, i diorama!
P.G. Ecco… il diorama in sé e per sé è stato esplorato in vari modi. Ho pensato che se riduco la serie dei quadri africani al titolo provocatorio di diorama, ne nasce un discorso scabroso su come vediamo l’altro, senza scarto rispetto a come vediamo un museo di storia naturale.
Anche il progetto sulle discariche lo voglio portare avanti. Grandi dipinti che indagheranno il mio continuo ondeggiare tra la pittura figurativa e non figurativa. Io non faccio grande differenza tra le due. È già accaduto cento anni fa, abbiamo capito tutti di che si tratta. La pittura è pittura e racconta se stessa. Puoi fingere di raccontare un vaso di girasoli, i tuoi zoccoli di legno, un asparago, un uomo che urla disperato su un ponte o un Papa che urla sul suo scranno, però poi alla fine il quadro, nella sua natura, nella sua concretezza, nel suo essere cosa, nel suo essere oggetto, nel suo essere testimonianza, coi segni aggrovigliati, lisci, faticati o disinvolti di chi lo ha fatto; è il quadro, è la pittura, questo è la pittura: pittura. C’è una serie di quadri divertenti di Dan Colen, che si chiama Birdshit, cacca di uccelli, che sembrano quadri di espressionisti astratti, dipinti con i colori acidi della cacca di piccione. Immagina degli uccelli appollaiati su un filo della luce per strada che cagano sulla tela. È una cosa divertente, Colen è sempre corrosivo e sarcastico – lo hai visto anche tu a cena quella sera a Venezia – ma dall’altra è interessante per capire che la pittura è pittura. Se dici che Birdshit è pittura espressionista astratta perché Colen ha usato modi alla Pollock, alla fine ti prendi per il culo da solo. Lui non ha preso per il culo Pollock, ha preso per il culo se stesso che stava facendo Birdshit in quel momento. Si è piegato a qualcosa di più grande di lui e come un giullare ha riso del re. Ha messo in discussione il senso della materia della pittura, perché la pittura può anche scherzare con se stessa come può prendersi dannatamente sul serio. C’è gente che dipingendo è arrivata a togliersi la vita e c’è gente che dipingendo scherza e di diverte, perché la pittura è più grande del pittore.
D.B. Bella chiusa.
P.G. Perché, abbiamo già chiuso?
D.B. Quasi… non andiamo troppo oltre altrimenti sembriamo troppo seriosi…
P.G. Non siamo stati seriosi per niente.
D.B. Due intellettuali del cazzo e stiamo sul cazzo.
P.G. Sei tu un’intellettuale del cazzo, io non sono un’intellettuale, io sono un pittore.
D.B. Ecco. Un difetto del pittore e uno dell’uomo Pietro Geranzani? Poi io confermo oppure no.
P.G. Il più grande difetto di Pietro Geranzani uomo è che è un pittore. Il più grande difetto del pittore Pietro Geranzani è che è un uomo.
D.B. Bella. E che sei maldestro.
P.G. Questo lo dici tu. Vorrei che chi ci legge ci vedesse entrambi in cucina.
D.B. No, meglio di no.
P.G. Tu rasenti l’incidente domestico letale ogni volta che tocchi uno sportello. Ogni volta che decidi di aprire la scatola dei Corn Flakes.
D.B. Bene, molto bene.
P.G. Se non ci fossi io saresti già morta denutrita. Meno male che mi piace cucinare.
D.B. Vero, e sei pure bravissimo! Ad ogni modo, stavolta, per concludere, non ti chiedo qual è per te il senso della vita, visto che in quella prima e unica intervista via mail mi avevi riposto citando Monty Python’s, “Non è niente di speciale”. E quando poi ci siamo messi insieme mi hai detto che mi avresti voluto insultare…
P.G. No, l’avevo trovata carina.
D.B. Lo dici adesso perché ti sto registrando.
P.G. No, l’ho trovata talmente stupida che era perfino carina.
D.B. Vaffanculo… e allora ora ti chiedo: come ti aspetti che sia l’ultimo vero viaggio? Quello che ci attende tutti alla fine, soli.
P.G. Ride. Come quello di Frodo. O era Bilbo?
D.B. Nel film non si vede dove va Bilbo.
P.G. Perché, si vede dove va Frodo?
D.B. Be’ c’è la nave, la luce…
P.G. Ok, Frodo. Non mettere sta divagazione qua. Oh cazzo è Frodo o è Bilbo! Altrimenti sembra che non lo abbia mai letto e invece l’ho divorato.
D.B. E invece ci metto tutto.
P.G. Ma no, vai a cagare.
D.B. E invece sì altrimenti che cazzo d’intervista moglie & marito è, scusa eh! Oh!
P.G. Non è così un’intervista tra moglie e marito.
D.B. Come no?
P.G. Ma tu non dovevi uscire?
D.B. Sì, infatti. Ecco questa è l’intervista che avremmo dovuto fare dodici anni fa.
P. G. Non avremmo potuto fare un’intervista del genere.
D.B. Perché?
P.G. Perché dodici anni fa cercavamo di scoprirci, di essere seducenti l’uno per l’altra.
D.B. Ma non è vero.
P.G. Io ti corteggiavo e tu ti lasciavi corteggiare. Era diverso.
D.B. Ma questo dopo. Io parlo di quella volta dell’intervista. Infatti io ora la volevo chiudere con le cose che mi hai detto l’altro giorno.
P.G. E che ti ho detto?
D.B. Io ti ho detto: ecco, questa è l’intervista che avremmo dovuto fare di persona dodici anni fa!
P.G. E perché non l’avevi voluta fare?
D.B. Perché poi ci avresti provato con me. Lo sai. Lo sentivo, lo sapevo.
P. G. Tu ci avresti provate con me.
D. B. Eh…
P. G. Eh.
*L’intervista è a cura di Dejanira Bada; le immagini si riproducono per gentile concessione di Pietro Geranzani (ritratto, in copertina, da Federico Garibaldi) e Fondazione Sangregorio
Le loro teste sono verdi e le loro mani sono blu
Pietro Geranzani in dialogo con Giancarlo Sangregorio
a cura di Angelo Crespi;
inaugurazione domenica 28 maggio ore 17,00.
Dal 28 maggio al 30 luglio 2023
Fondazione Sangregorio Giancarlo
Via Cocquo, 19, 21018 Sesto Calende VA
Intervista tratta dalla rivista culturale Pangea.news